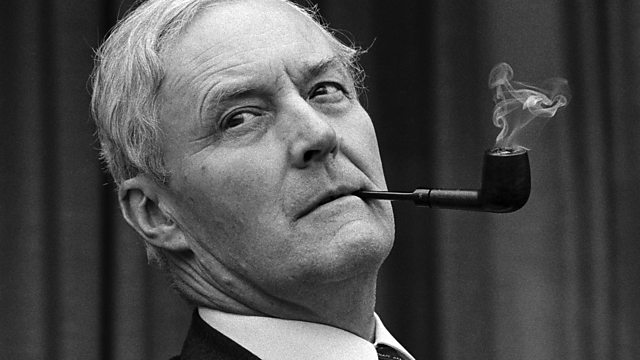1. Provaci ancora, Ludwig! Le tre versioni del "Fidelio"
Ebbene, nel 1805 l'opera (o meglio, come abbiamo detto, il Singspiel) era pronta per andare in scena al Theater an der Wien. Un momento perfetto per Beethoven: poteva finalmente coronare il suo desiderio di scrivere per il teatro in musica con un'opera che parlava di libertà e di lotta contro la tirannia. C'era solo un piccolo problema: Vienna, nel 1805, era occupata dall'esercito di Napoleone che aveva sconfitto le armate austriache e così quel 20 novembre 1805 il pubblico del teatro in cui si rappresentava Fidelio era costituito prevalentemente da soldati francesi, come possiamo vedere nell'immagine:
Risultato: la prima fu un insuccesso e possiamo anche immaginare il motivo di tanta freddezza da parte del pubblico: semplicemente, come possiamo vedere nell'immagine seguente, a qualcuno sembrò che il messaggio antiautoritario del Fidelio fosse un invito nemmeno troppo velato alla ribellione contro l'oppressore francese.
Beethoven però non si diede per vinto. Credeva in quello che aveva scritto, si rese conto che l'opera soffriva di qualche lungaggine, la rimaneggiò un po' e nel 1806 la rappresentò di nuovo. A questo punto, i Francesi se n'erano tornati a casa loro riportando certo un'immagine molto vivida della ridente Vienna...
 |
"Pensi che Beethoven parli di noi nel 'Fidelio'?"
"Ma no... cosa Le fa pensare questo, mio Imperatore?"
|
 |
| "Com'è andato il tuo viaggio in Austria?" "Mah... sai, gli Austriaci sono matti, dicevano sempre 'Fidelio' e ci guardavano..." |
Quindi, per riassumere, Beethoven scrisse tre versioni del Fidelio:
- La prima versione fu rappresentata nel 1805 di fronte a un Theater am Wien pieno di soldati francesi
- La seconda versione fu rappresentata nel 1806
- La terza versione, che è quella che viene rappresentata oggi, fu rappresentata nel 1814
2. Cherchez la femme: Wilhelmine Schoeder-Devrient e il successo di "Fidelio"
Comunque, nonostante tutti gli sforzi di Beethoven per scrivere e riscrivere l'opera, Fidelio continuava a non avere successo. L'opera rischiava di cadere nell'oblio, ma improvvisamente ecco che negli anni Venti dell'Ottocento Fidelio iniziò ad essere rappresentato un po' ovunque in Germania e in Austria. Perché? Il merito della (ri)scoperta di questo Singspiel da parte del mondo di lingua tedesca è tutto da attribuirsi alla celebre cantante d'opera tedesca Wilhelmine Schröder-Devrient.
Frau Schröder-Devrient, che aveva un amore per le acconciature stravaganti, come possiamo vedere nella seguente immagine...
 |
| Immagine proveniente da http://www.belcanto.ru/media/images/persons/schroder.jpg |
...è una figura estremamente importante nella storia della musica per vari motivi: oltre ad permesso il successo del Fidelio, infatti, ella sostenne molto Wagner nei suoi primi passi nel mondo dell'opera, quando, negli anni Quaranta dell'Ottocento, sia lei che il buon Richard vivevano a Dresda. Wilhelmine invitò più volte il futuro autore del Ring a casa sua e, soprattutto, cantò nella prima rappresentazione di molte sue opere (Rienzi, L'Olandese volante, Tannhäuser) in una fase in cui Wagner non era il compositore di successo che sarebbe diventato, ma semplicemente un trentenne di belle speranze il cui soggiorno a Parigi, qualche anno prima, si era risolto in un sostanziale nulla di fatto. Questo supporto le valse la gratitudine del buon Richard e il che non è poco, avendo Wagner una certa abitudine a parlare male di tutti (chiedere a Meyerbeer per maggiori informazioni).
Ma torniamo a Fidelio. Wilhelmine Schröder-Devrient aveva cantato nel Fidelio quando aveva diciassette anni e aveva amato molto l'opera; pertanto, quando divenne famosa, portò Fidelio nei teatri di tutta la Germania, riscuotendo un notevole successo. L'opera entrò nel repertorio per non uscirne mai più.
Grazie, Wilhelmine!
Grazie, Wilhelmine!
3. Le tre "Leonore" di Beethoven
A questo punto, sappiamo tutto di Fidelio: di cosa parla, quando fu rappresentata, come arrivò ad essere amata dal pubblico. Ma ancora non abbiamo detto niente dell'argomento da cui siamo partiti, ossia la sostituzione di ouverture effettuata da Baremboim all'ultima prima della Scala.
Allora, abbiamo detto che Beethoven rimaneggiò molto la sua opera e uno degli elementi che furono oggetto di maggiori ripensamenti fu, appunto l'ouverture. Quando nel 1814 l'edizione definitiva di Fidelio va in scena, già quattro ouverture si sono avvicendate nei progetti del compositore.
Nel 1805, per la prima rappresentazione dell'opera (sì, quella dei soldati francesi), Beethoven scrive l'ouverture che ora è nota come Leonora II...
Ehi, ma manca qualcosa: e la Leonora I dov'è? Be', la Leonora I fu scritta per una rappresentazione del Fidelio che doveva avere luogo a Praga (e che poi non ci fu).
Ebbene, tutte e tre queste ouvertures furono poi scartate dall'autore, che nella versione definitiva dell'opera, nel 1814, optò per un brano più conciso (7 minuti contro gli oltre 15 delle varie Leonore) e sicuramente meno suggestivo musicalmente che è quello che è tuttora viene eseguito prima dell'opera. Perché? Allora, i problemi che Beethoven individuava nelle tre Leonore erano essenzialmente due:
- In primo luogo erano lunghe, molto (forse troppo) lunghe
- Inoltre (e questo è forse l'aspetto più importante) rivelavano già al pubblico l'unico colpo di scena dell'opera, ossia la comparsa improvvisa, alla fine del Fidelio, del ministro del re che salva Florestano e Leonora. Infatti, come abbiamo detto, la comparsa del ministro del re è accompagnata da uno squillo di tromba: ebbene, in tutte e tre le Leonore noi ritroviamo quello squillo di tromba, squillo che è invece assente nell'ouverture che poi Beethoven scelse come definitiva. In pratica, Beethoven deve aver ragionato in questo modo: "Non posso rivelare dall'inizio come va a finire l'opera!" E quindi le tre Leonore, splendide ma con spoiler incorporato, non vennero incluse nell'edizione definitiva del Fidelio.
Comunque, queste tre ouvertures non caddero nel dimenticatoio. Furono molto eseguite come pezzi da concerto e, proprio per la presenza di quello squillo di tromba, sembrò al pubblico che esse raccontassero una storia: la storia di Leonora, di Florestano, di Don Pizarro. In breve: la storia del Fidelio. E ispirarono dunque altri autori che volevano raccontare delle storie tramite la musica sinfonica, rappresentando il primo passo verso quello che poi sarebbe diventato il poema sinfonico.
Ma questa è un'altra storia e mi farà piacere raccontarvela, prima o poi.
Per il momento, spero che abbiate compreso il motivo della mia scarsa comprensione per la scelta di Baremboim: sostituire l'ouverture del Fidelio con la Leonora II vuol dire non comprendere i motivi - in primo luogo drammaturgici, come abbiamo visto - che portarono Beethoven a prendere determinate decisioni per la versione definitiva dell'opera. Di più, vuol dire tradire la volontà di Beethoven, visto che fu lui a non mettere nessuna delle tre Leonore come ouverture della versione del 1814 dell'opera. So che le Leonore sono belle, ma se proprio ti piacciono, Daniel, potevi perlomeno fare come faceva Mahler (poi imitato da altri), che eseguiva l'ouverture del Fidelio all'inizio del primo atto e poi, prima del secondo atto, eseguiva la Leonora III. Comunque, spero che abbiate apprezzato il Fidelio. A presto e...
Stay tuned!